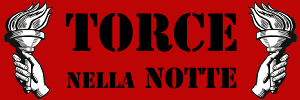Malala Yousafzai (1997)
attivista musulmana, femminista e socialista, contro il fondamentalismo islamico.
Sono ormai decenni che i nostri governi e media, hanno fatto di tutto per avvalorare l’idea menzognera, che Islam e fondamentalismo islamico/terrorismo siano la stessa cosa. Certo è più facile, è più conveniente, certo non possono ammettere di essere i principali responsabili dei problemi dell’Africa o del Medio Oriente.
Nella “nostra” concezione biancocentrica, neocolonialista e patriarcale, l’unica descrizione possibile dell’Islam, è che gli uomini siano tutti potenziali terroristi e le donne schiave impassibili della loro sottomissione, vittime bisognose di una bianca democratica mano che strappi loro di testa un velo.
Eppure basterebbe considerare che la libertà per definizione non può essere imposta da terzi, perché diventa sovradeterminazione, cioè il suo opposto.
Se non liberiamo noi stessə, ogni giorno, è impossibile si possa cambiare la società di cui facciamo parte.
Finché considereremo identitarie e insindacabili tutte le cose che finora ci hanno diviso, la pace non arriverà mai.
Non è con appiattimento e l’omologazione che arriverà la pace, ma con il rispetto e la collaborazione reciproca. Ed è questo il punto: la pace non è redditizia. La pace non vende armi. All’Occidente che Africa, Medio Oriente, Asia etc. siano scenario di guerre, genocidi e atrocità, fa troppo comodo.
Per questo motivo che ho scelto di raccontare la storia di Malala, Malala è la prova vivente della slealtà e dell’ipocrisia occidentale. Spesso nelle interviste le chiedono come sia possibile che una ragazzina di fede musulmana lotti per i diritti delle donne e si batta contro l’integralismo, e lei risponde:
“Islam vuol dire pace e ciascuno di noi
ricopre un ruolo fondamentale nell’affermazione della pace,
poiché la società si sviluppa a partire dai singoli.”
E in effetti anche etimologicamente Islam deriva dal’unione di salima (essere saldi) e salam (pace).
Attivista in Pakistan dall’età di 11 anni, attraverso il suo blog, racconta le attività dei talebani pakistani che occupano lo stretto di Swat e calpestano i diritti delle donne.
Il 9 ottobre 2012, lo scuolabus che riporta Malala a casa, viene fermato da uomini armati che fanno irruzione sul mezzo e le sparano in testa. L’ attentato viene prontamente rivendicato dai talebani che la definiscono “simbolo per gli infedeli e dell’oscenità”.
Nonostante la brutalità dell’attentato però, Malala si salva e trova asilo politico in Inghilterra.
Un anno più tardi, ospite al Palazzo di Vetro (ONU) di New York, lancerà un appello per l’istruzione di tuttə lə bambinə del mondo, indossando lo scialle appartenuto al ex prima ministra pakistana Benazir Bhutto, assassinata dai talebani nel 2007.
Qualche mese dopo, a Strasburgo, le verrà conferito il Premio Sakharov per la libertà di pensiero, e l’anno seguente il Nobel per la Pace, che condividerà assieme all’attivista indiano Kailash Satyarthi.
Molte scuole pakistane sceglieranno il 20 novembre come, I’m Malala day, giornata nazionale del diritto all’istruzione per l’infanzia. Nella sua autobiografia, Io sono Malala, in alcune righe scrive anche dell’opposizione del padre al divieto del romanzo I versi satanici di Salman Rushdie. Il libro in questione infatti, contiene una rivisitazione romanzata in chiave onirica dell’episodio sulla presunta ispirazione diabolica di Maometto. Il testo fa riferimento a delle sūre censurate in molti testi che hanno come protagoniste tre antiche divinità femminili pagane, considerate in seguito come sataniche. Il libro costerà a Salman Rushdie la condanna a morte per bestemmia.
Per questo motivo un’associazione di scuole private pakistane indirà anche il “I am not Malala day” definendo il libro “antislamico e antipachistano”.
Nella mia ottica, premi, medaglie o qualsiasi voglia altro tipo di titolo, valgono poco e nulla. Restano per lo più, se non del tutto, una mera operazione di facciata, e non è certo questo che mi ha spinto a scegliere di raccontare la storia di Nadia, Malala, Irena etc. Quello che mi ha spinto a raccontarle sono l’impegno e la determinazione a rischio della propria vita per il conseguimento del bene comune, e non solo di una ristretta categoria di persone.
Non “prima questo o quello”.
Sarebbe ora di smetterla di ammazzarci per rubare le briciole da sotto la tavola dei potenti. Le briciole sbavate dagli assassini non riempiranno mai la voragine che abbiamo dentro. Non saranno vestiti, telefonini o foto di vacanze a riempirlo.
Trovo assai triste che questo spazio sia da sempre riempito da boria e arroganza.
Sembra importare poco che anche questo abbia un costo. Ci fa marcire dentro.
Ritengo perciò che l’unico modo per rendere il mondo un posto migliore, sia mettere la propria esistenza a servizio dellə altrə. Credo sia questa la più grossa eredità e ricchezza dell’umanità.