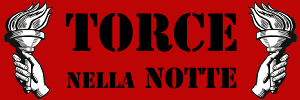Maria Occhipinti (1921-1996)
Scrittrice, anarchica, antimilitarista e femminista.
Nasce a Ragusa, il 29 luglio 1921. D’indole curiosa e inquieta, insofferente all’ambiente piatto e bigotto della sua città, abbandona la scuola dopo la terza classe per fare l’apprendistato di sarta. Si sposerà a soli 17 anni e poco dopo il marito sarà chiamato alle armi. Nel 1944, finita la guerra, s’iscrive al CLN, suscitando grande scandalo, ma facendo proseliti tra le operaie del suo quartiere.
La situazione in Sicilia non è certamente delle migliori. Lə contadinə affamatə occupano i terreni incolti confidando nei decreti Gullo che mai saranno rispettati. Ogni protesta sarà repressa dalla polizia con il sangue, come nella “strage del pane” a Palermo, in cui moriranno 24 persone e ne saranno ferite 158, la maggior parte minorenni. Durante il governo Bonomi/Badoglio, l’esigenza di ricostituire l’esercito italiano, verrà appoggiata anche dei partiti di sinistra, con annessa pioggia di cartoline precetto. Ricordiamo che all’epoca gli uomini non erano solo padri e figli, ma rappresentavano anche l’unico sostentamento economico per le famiglie, già ridotte alla fame dalla guerra. Maria quindi, deciderà di farsi protagonista delle campagne e azioni antimilitariste “Non si parte”, estese in tutta la Sicilia. Incinta di cinque mesi, si distenderà davanti alle ruote di un camion che rastrella i giovani della città, riuscendo a bloccarne la marcia e permettendo così la fuga dei prigionieri. Il gesto della giovane e l’orrida risposta dei soldati che uccideranno un ragazzo durante i tafferugli, infiammeranno gli animi dellə cittadinə. La rivolta sarà sedata dopo 3 giorni, con uccisioni e centinaia di arresti. Maria verrà inviata al confino a Ustica, dove partorirà e sarà quindi trasferita al carcere palermitano delle Benedettine. Tornata a casa subirà l’ennesima umiliazione. Non solo sarà ripudiata dal marito, dalla sua famiglia e dallə compaesanə, perché non sottomessa alle logiche patriarcali; ma anche dal PCI, che definirà i moti del Non si parte come “rigurgiti fascisti”. Solo lə anarchichə le apriranno le porte, rendendole il giusto merito. Lasciato quindi il PCI per il movimento anarchico, si impegnerà in iniziative contro povertà, schiavitù e per l’emancipazione delle donne. Assieme la figlia lascerà Ragusa, per vivere oltre 25 anni in giro per il mondo: Napoli, Sanremo, Roma, Svizzera, Marocco, Francia, Canada, America, Hawaii e Messico.
Nel periodo svizzero scrive l’autobiografia Una donna di Ragusa, pubblicata nel 1957 e ristampata nel 1976 da Feltrinelli.
Sebbene Maria avesse solo la terza elementare, troverà attraverso una scrittura semplice e cruda, una valvola di sfogo. Attraverso note intime e private unite alla dimensione letteraria riuscirà a ritrarre il popolo siciliano anche nei suoi lati più grotteschi. Secondo lei, infatti, il povero doveva essere raccontato con la dignità del povero e nel del ricco.
Prima di partire dal Canada verso l’America, sua figlia deciderà di non seguirla, desiderosa di trovare quella stabilità che pensava la madre le avesse negato per egoismo. Per Maria sarà l’ennesima stilettata al cuore. Maria l’aveva portata via da una Sicilia, dove sua sorella Rosina, ancora subiva le calunnie e il bigottismo dellə ragusanə. Rosina infatti non si sposerà mai, però continuerà a camminare per le strade della sua città a testa alta, occupandosi anche lei di volontariato e diritti civili.
Maria cercava un approdo dove la figlia potesse crescere senza patire i pregiudizi che aveva patito lei e stava patendo Rosina e per riuscirci da sola farà qualsiasi tipo di lavoro.
Un’ ulteriore strazio sarà volare da Los Angeles alla Sicilia per salutare la madre morente, nella speranza di una riconcigliazione. Arrivata però, sua madre non vorrà comunque saperne di vederla.
Tornata in Italia nel 1973, si stabilirà a Roma, impegnando le sue energie nella causa femminista e antimilitarista, mantenendo stretti legami col movimento anarchico e collaborando per varie riviste.
Durante la crisi dei partiti nel 1979, quando lə socialistə le chiederanno di candidarsi al parlamento europeo, risponderà così:
“Preferisco mangiare pani e cipudda, non voglio andare con nessun partito perché perderei la libertà”.
Nel 1987 terrà un comizio contro i missili Cruise della NATO a Comiso e si impegnerà strenuamente contro l’uso del nucleare.
Morirà a Roma, per le conseguenze del morbo di Parkinson, il 20 agosto 1996.
“Mi sentivo straniera in patria,
perseguitata e incompresa.
Allora ho cominciato a girare per il nord Italia,
per la Svizzera, Francia, Inghilterra,
Marocco, Stati Uniti, Hawaii e Messico.
Facevo la bambinaia,
l’aiuto sarta, la pellicciaia,
ho saldato persino le corde delle navi
per vivere”.