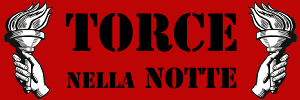Ottorino Manni (1880 – 1925)
Scrittore e giornalista, anticlericale, sindacalista e anarchico.
Lotterà per l’emancipazione delle persone oppresse e per il raggiungimento della libertà sociale, ritenuta possibile solo grazie alla rivoluzione.
All’età di sei anni si ammala gravemente di una malattia degenerativa che gli causerà l’amputazione di una gamba e di un braccio. Confinato la maggior parte del tempo in casa su una sedia a rotelle, troverà conforto nella lettura, nella scrittura e nel collezionismo di libri.
In giovane età si interessa al libero pensiero e al post-illuminismo e dopo aver letto delle gesta di Malatesta e compagnx su un numero di Agitazione, sposerà il razionalismo con l’ideale anarchico.
Fino all’avvento del Fascismo, sarà corrispondente di numerose testate, prevalentemente anarchiche, pubblicate a Senigallia. Diventando così, un punto di riferimento per lə libertariə della zona. Nemmeno le insormontabili barriere architettoniche di una società fatta a misura di “uomo abile” riusciranno ad allontanarlo dalle strade e dalle piazze. Ottorino troverà un suo personale modo per essere partecipe alla vita sociale. Presterà infatti la voce per comizi, dibattiti e conferenze in supporto allə lavoratorə. Sfrutterà lo spazio datogli su Libero Pensiero per diffondere l’eco delle lotte operaie ,oltre che per incitamenti anticlericali, antimilitaristi e astensionisti.
All’avvento della guerra, guiderà infatti una campagna antibellica che lo renderà noto anche nel resto d’Italia e lo coinvolgerà in fitte corrispondenze con lə principali esponenti anarchichə del tempo.
La sua casa si trasforma da studio solitario a luogo di ritrovo e fermento, in cui cene fra amichə diventano riunioni anarchiche, in barba al pietismo della polizia fascista che data la sua condizione fisica, non lo ritiene “soggetto pericoloso”.
Dopo la prima guerra mondiale, collaborerà alla ricostituzione di vari gruppi anarchici e Malatesta gli invierà la tessera di giornalista collaboratore, per Umanità Nova. Tuttavia l’ascesa del fascismo limiterà fortemente la sua attività di scrittore e giornalista.
Muore a Senigallia il 17 gennaio 1925, ai suoi funerali partecipano oltre 2000 persone e ci sarà un massiccio dispiegamento di forze di polizia. Alla fine del discorso funebre, pronunciato da Sergio Sabatini, la sbirraglia fascista ordina invano allə partecipantə di disperdersi, ma lə compagne riusciranno ad accompagnare la salma fino al cimitero. Su espressa richiesta, Ottorino vorrà una cerimonia libera da riti religiosi, decidendo di devolvere eventuali offerte alla stampa libertaria o allə figliə dellə carceratə.
Sceglierà anche il testo per la propria lapide:
“Ottorino Manni,
Straziato da cento malattie,
sorretto da una sola idea,
tutto sfidò,
sempre lottò da forte.
Le sue ossa alla terra,
i suoi scritti alle genti.“
“Di lui non vi colpiva che il sorriso tenero e affettuoso,
e non si rimarcava che la bella testa di pensatore e di asceta.
Il dolore aveva affinato i tratti del suo volto, aveva messo un pallido riflesso di luna nel suo buon sorriso fatto di comprensione,
di coraggio e di dolcezza;
aveva reso il suo sguardo rassegnato, aperto e profondo.
Non un accenno alle sue infermità;
non un ricordo su tutto ciò che aveva sofferto;
non una parola mi disse su quanto di certo avrebbe ancora penato;
solo volle dirmi, ed a più riprese, la grande gioia d’essere insieme ai compagni, l’infinita soddisfazione di poter essere anche lui alla conferenza l’indomani. “Mi porterete, non è vero?” aveva domandato sottovoce ad alcuni suoi intimi amici. “Sono diciotto anni che non esco più di casa; ma domani non vorrei mancare, e voi che siete sempre stati così buoni verso di me, voi mi porterete… sulle vostre braccia… non è vero?”
Io guardavo meravigliata quella mesta tranquillità:
quel miracolo di coraggio e di resistenza;
e cercavo di cogliere;
ma invano, nel mistero di quello sguardo,
un’espressione di segreta amarezza,
di occulta disperazione,
che tradisse l’angoscia di tante ferite nascoste;
cercavo di penetrare il fondo di quell’animo per strappargli il segreto di quella saggezza, (…)
un raggio di sole
che illuminava tante rovine
e tanta desolazione. (Virgilia D’Andrea da Torce nella notte)