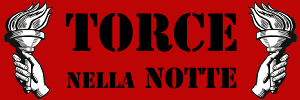Lucy Parsons (1851/53-1942)
Sindacalista, oratrice, giornalista, femminista e anarchica.
Sulle sue origini troviamo due versioni distinte, lei si è sempre rivendicata una discendenza messicana e nativa Creek, dicendo di essere nata in Texas nel 1853 e di essere rimasta orfana a tre anni.
La seconda versione invece, le attribuisce la nascita in Virginia nel 1851 da madre afrodiscendente e che il padre biologico di Lucia fosse proprio lo schiavista che “possedeva” sua madre Charlotte, tale Thomas J. Taliaferro, originario della Virginia, (ricerche mi hanno confermato che la famiglia Taliaferro era nota in Virginia per il commercio di schiavə). Secondo quest’ultima teoria quindi, durante il trasferimento a piedi dellə schiavə in Texas, Charlotte scapperà con la piccola Lucia stabilendosi a Waco in Texas, una città con un alta concentrazione di nerə liberatə, dal momento che era praticamente l’unica a offrire loro lavoro alternativo alle piantagioni.
Sicuro in entrambi i casi è che Lucia crescerà in Texas.
Nel 1821, il Texas Messicano si emancipa dal colonialismo spagnolo, dichiarandosi Repubblica federale e abolendo la schiavitù nel 1829. Tra il 1821 e il 1822, Moses Austin e suo figlio, con autorizzazione spagnola, faranno arrivare 300 famiglie anglo-sassoni a San Felipe de Austin. (Esattamente come ha fatto pochi anni fa la Turchia ad Afrin con le famiglie jihadiste). Gli Austin saranno anche i fondatori di una milizia che in seguito si trasformerà nella Texas Ranger Division. I coloni riprenderanno a impiegare schiavə nelle piantagioni, rifiutandosi di riconoscere il governo messicano.
Nonostante i tentativi decoloniali, il Texas entrerà negli Stati Confederati d’America il 1º marzo 1861, capitolando nel 1865 e venendo reintegrato nell’Unione il 30 marzo 1870.
Il periodo della “ricostruzione” sarà caratterizzato da: segregazione razziale, orrore, violenza schiavista e una profonda crisi agricola.
Essendo quindi il Texas diventato americano, nei suoi documenti Lucia non solo figurerà cittadina americana e “bianca”. La “razza” infatti, doveva necessariamente essere attribuita e non per autodichiarazione. Questo, per quanto mi riguarda, conferma che stabilirne le origini precise fosse irrilevante, al cospetto dei presupposti “legalmente” razzisti del governo americano.
Durante il suo impegno politico come sindacalista, la stampa reazionaria la prenderà di mira accusandola di essere “nera”, mentre parte della comunità nera l’accuserà di avere rinnegato le proprie origini. Lucia in merito, manifestando un evidente fastidio per l’uso strumentale della questione, dirà: “Non essendo candidata per un incarico pubblico, la mia vita privata non è di competenza dell’opinione pubblica.”
(E qui si potrebbe aprire un lungo discorso sulle conseguenze nefaste di tutte le diaspore, sui censimenti razziali tutt’ora tanto in voga nel mondo, ma mi perderei in eterne divagazioni.)
Lucia ad ogni modo apparteneva un genere considerato non conforme, aveva una pelle giudicata non conforme, ma soprattutto, aveva idee politiche non conformi al mantenimento dello stato di oppressione generale, in un periodo in cui la “red scare” terrorizzava l’opinione pubblica.
Molto giovane si interesserà infatti alla politica, aderendo al SLP (partito socialista del lavoro) e all’International People’s Association (organizzazione anarchica).
Nel 1871 sposerà l’anarchico, nonché noto abolizionista, Albert Parsons e cambierà il suo nome in Lucy, due anni dopo si trasferiranno a Chicago.
Proprio a Chicago, Lucy inizierà a scrivere articoli sull’emancipazione femminile e il diritto al voto e sarà impegnatissima nell’attività sindacale. Prenderà parte a numerosi scioperi, nei quali spesso sarà oratrice.
La polizia la definirà più pericolosa di 1000 ribellx.
Le condizioni di lavoro per lə operaiə sono miserabili, moltə di loro lavorano anche dodici ore al giorno, sei giorni alla settimana, in condizioni spesso letali.
Il 3 maggio del 1886, lə scioperantə si incontrano di fronte alla fabbrica di mietitrici McCormick e vengono immotivatamente caricatə dalla polizia, il bilancio sarà di due morti e numerosi feriti.
In risposta a questo orrore, sarà organizzato un presidio anarchico a Haymarket Square. La quiete iniziale andrà in frantumi, quando all’improvviso e senza motivo, i gendarmi a cavallo inizieranno a disperdere lə dissindentə. Poco dopo esploderà un ordigno, che nonostante le piccole dimensioni, ucciderà un poliziotto dando vita a un massacro: 11 mortə e numerosi feritə, fra cui sette agenti colpiti dai loro stessi colleghi.
Otto anarchici saranno accusati di omicidio e altri capi d’accusa, fra questi ci sarà anche Albert Parsons.
Nonostante la completa assenza di prove, la giuria giudicherà gli imputati colpevoli. Solo uno si salverà dalla forca, scontando però 15 anni di reclusione.
Questo fatto darà luogo a manifestazioni internazionali e sarà ricordato come la vicenda dei Martiri di Chicago che propagata la sua eco per il mondo, insinuerà in molti cuori il tarlo ardente dell’ anarchia.
Albert dal carcere, prima di morire scriverà a Lucy di non struggersi di dolore per lui, ma di proseguire nella lotta, e così sarà.
Lucy continuerà l’attivismo politico, fondando la testata Freedom, collaborando con svariate testate e associazioni impegnate contro il razzismo, il sessismo e promuovendo la lotta di classe diventerà una delle voci più riconosciute nel movimento anarcosindacalista americano. Sarà inoltre membro de’ Industrial Workers of the World (IWW).
Nel 1932 sosterrà strenuamente il sindacalista afrodiscendente Angelo Herndon durante l’iter processuale in cui verrà accusato “di unire bianchə e nerə nella lotta contro i padroni.”
Lucy morirà ultranovantenne in un incendio nella sua casa, nel 1942.
“Anche se nell’attuale, caotica e vergognosa lotta per l’esistenza,
la società premia: avidità, crudeltà e inganno;
possiamo comunque trovare persone in disparte
che quasi sole nella loro determinazione,
lavorano per il bene, piuttosto che per l’oro.”