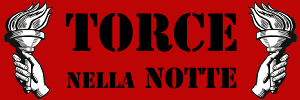Louise Michel (1830-1905)
Poetessa e scrittrice, insegnante, oratrice, rivoluzionaria anarchica,
antesignana del femminismo intersezionale.
Nata fuori dal matrimonio, viene cresciuta in casa dei nonni, presso la quale sua madre lavora come domestica. I nonni ci terranno particolarmente a fornirle un’istruzione. Louise si appassionerà di storia come di letteratura e giovanissima prenderà coscienza riguardo le ingiustizie sociali, riuscendo a vedere oltre ogni possibile confine, a partire da quello di specie. Sarà proprio la violenza che vedrà esercitare sullə animalə a dare inizio a questa consapevolezza, dotandola di un’empatia incredibile verso le categorie più reiette della società. Già da piccola inizierà a rubare nella agiata casa dei nonni per distribuire la refurtiva a chi ne avesse davvero bisogno.
Diventata maestra, ma non volendo giurare fedeltà all’imperatore, aprirà la sua prima scuola.
Alla morte del nonno, ricevuta un’eredità cospicua, la darà interamente in beneficenza suscitando lo scandalo nei benpensanti del paese e pertanto si trasferirà a Parigi.
Fra il 1865 e il 1868, aprirà altre due scuole, presentando progetti per la creazione di istituti professionali e orfanotrofi non religiosi, con l’obiettivo di fornire un’istruzione a chi generalmente ne é privato, discriminato per ceto o genere. Scriverà inoltre anche articoli per vari giornali e poesie sotto lo pseudonimo di Enjolras, nome di un personaggio di Victor Hugo, con cui si scrive già da quasi vent’anni.
Nel 1870 vestita “da uomo”, armata di un pugnale e in cerca di vendetta, prenderà parte alla veglia funebre di Victor Noir, giornalista ucciso dal cugino di Napoleone III e scandalosamente assolto.
Dopo la caduta dell’Impero, diverrà inoltre una delle figure emblematiche della Comune di Parigi e sarà eletta presidente del Comitato di vigilanza di Montmartre, dove combatterà sulle barricate e fornirà supporto umano e tecnico allə bisognosə. Nella Parigi assediata e affamata, Louise sosterrà con forza la proposta (inascoltata), di lanciare un’offensiva contro Versailles, offrendosi volontaria per uccidere Thiers.
Travestita da guardia nazionale riuscirà a ingannare e scappare dalle truppe di Thiers anche quando prenderanno il sopravvento.
Solo dopo aver appreso dell’arresto di sua madre, si consegnerà prigioniera per farla liberare.
L’accuseranno di: tentato colpo di Stato, detenzione d’armi, falsificazione di documenti, istigazione alla guerra civile e di essere «ambiziosa di elevarsi al livello dell’uomo, superandolo nei vizi».
Louise rifiuterà di difendersi in quanto sostenitrice assoluta della rivoluzione sociale, sfidando la corte di condannarla a morte in quanto non pentita, ma fiera del suo operato.
«Se mi lascerete vivere, esorterò incessantemente alla vendetta»
Condannata alla deportazione a vita e reclusa per venti mesi nell’abbazia di Auberive, verrà deportata in Nuova Caledonia, dove resterà sette anni. Lì redigerà un suo giornale, scriverà Légendes et chansons de gestes canaques, popolazione autoctona dell’isola, con cui avrà un importante scambio culturale e che sosterrà nella rivolta contro i coloni francesi.
Successivamente aprirà una scuola libera nel capoluogo dell’isola, per istruire lə figliə dellə deportatə.
Ottenuta la grazia, un anno più tardi, sarà salutata da una folla di nativə che la lasceranno partire solo dopo averle fatto promettere di tornare.
Tornata in Francia, qualche anno dopo, è nuovamente arrestata per questioni politiche con altri compagni. Prenderà talmente male la proposta di scarcerazione, in quanto unica donna del gruppo, da distruggere la sua cella e rischiando addirittura l’internamento in manicomio. Tuttavia, sarà rilasciata.
Trasferitasi a Londra, gestirà una scuola anarchica per tornare a Parigi definitivamente nel 1904.
Gli ultimi anni li spenderà in conferenze e visiterà per tre mesi l’Algeria.
Muore a Parigi nel 1905.
Al funerale, libero da riti religiosi, parteciperanno 120.000 persone.
All’anniversario della sua morte, ancora oggi, la sua tomba nel
cimitero di Levallois-Perret, viene coperta di fiori.
«Ah, gli esseri inferiori, ecco il pretesto d’ogni dominazione!
Inferiori perché?
Perché altri più violenti, o più astuti, riuscirono ad assoggettarli
o ucciderli?…
Non sono invece inferiori di senso morale quelli che formano la
felicità propria sulla infelicità altrui divorando, sfruttando, asservendo?
Voi mi risponderete con la dura legge di selezione, col trionfo del
più adatto, con l’impero del più forte.
Ma io conosco un’altra legge, che non è di oppressione né di morte
– ma di libertà e di vita: quella della solidarietà…
Voi vi deliziate degli uccellini allo spiedo,
e io preferisco il trillo del cardellino, che canta là, su quell’ albero,
a tutte le orazioni di voi avvocati…
Diversi sì, inferiori no…»
« – Ma tra l’umanità, e le altre specie zoologiche…» azzardai io.
« – Ebbene – incalzò l’ardente vegliarda – è appunto perché l’umanità
volle calpestare gli altri esseri, che voi chiamate inferiori,
che essa si trovò esercitata ad inferocire e a dilaniar sé stessa.
Le razze inferiori, le classi inferiori, il sesso inferiore, che per dileggio
chiamate gentile – ecco la stessa classificazione trasportata
dal campo animale a quello umano…
Ma la lotta, direte, fu la condizione d’ogni progresso… Sì, ma io
non amo la lotta per la lotta; la voglio solo perché da essa scaturisca
invece dell’antagonismo la fratellanza di tutti gli esseri…»
(Tratto dall’introduzione di Pietro Gori de La Comune di Louise Michel)